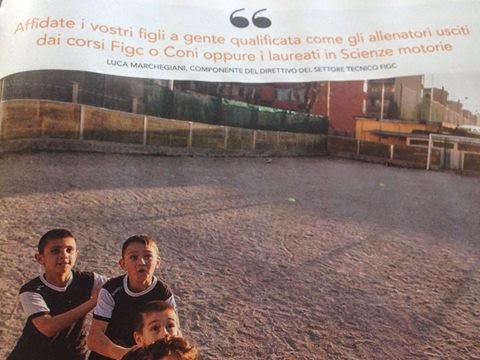PRINCIPI METODOLOGICI E DIDATTICI PER LA CATEGORIA ESORDIENTI:
INTRODUZIONE
In
questo lasso di tempo avviene il passaggio dalla fanciullezza alla pubertà e
all’adolescenza. In questo salto verso un modo di esistere più vicino a
quello degli adulti sono le ragazze a partire per prime e infatti il loro
ingresso in pubertà avviene intorno ai 10 anni mentre per i maschi l’inizio
pare identificarsi tra gli 11 e i 12 anni. L’adolescenza è sicuramente il
periodo più difficile nella storia evolutiva del giovane sportivo. Il suo
bisogno irrefrenabile, impaziente, di divenire adulto deve fare i conti con dei
tempi di maturazione spesso lunghi che angosciano il giovane soprattutto quando
deve confrontarsi con coetanei a sviluppo precoce. Dagli 11 anni fino alla
maturità, il giovane atleta è una persona ricca di conflittualità e contraddizioni
che emergono in modo a volte drammatico nell’esperienza sportiva.
Sviluppo fisico e motorio
Durante
la fanciullezza vi è un marcato equilibrio nel rapporto peso - altezza che
tende invece a modificarsi durante la pubertà. Se inizialmente il rapporto può
avvantaggiare l’aspetto ponderale, intorno ai 12/14 anni è l’aumento
dell’altezza a segnare il cambiamento dell’immagine corporea del soggetto.
Questo
cambiamento determina delle disarmonie: spesso i segmenti corporei non si
allungano contemporaneamente, la muscolatura è inadeguata all’allungamento, il
soggetto appare goffo e sgraziato. Tutto questo genera anche un vissuto
psicologico ricco di conflittualità.
I
cambiamenti fisici e in altezza non sono spesso omogenei e armonici. Sovente a
un accrescimento repentino possono corrispondere delle cadute di rendimento
soprattutto sul versante coordinazione spazio - tempo.
L’ingresso
nella pre-adolescenza prevede l’innesco della tempesta ormonale che
caratterizzerà il periodo adolescenziale.
Un
elemento da considerare con attenzione è legato alla diversità soggettiva dei
ritmi di accrescimento. La precocità e la tardività dello sviluppo possono
generare dei problemi e allora è importante rassicurare il ragazzo facendogli
capire che ognuno ha i suoi tempi di maturazione.
Lo sviluppo cognitivo
Il
pensiero concreto secondo Piaget intorno agli 11 anni viene sostituito da un
più strutturato pensiero logico formale che gli permette di ragionare anche in
funzione di ciò che non è percettivamente presente: la reversibilità del
pensiero si fa anch’essa più marcata. I cambiamenti a livello intellettivo,
intorno agli 11 anni, sono qualitativamente e quantitativamente importanti.
Fornire istruzioni al ragazzo di questa età è molto più semplice perché c’è
meno bisogno di esemplificazioni visive; l’istruzione verbale è utilizzata più
facilmente perché il bambino, distaccandosi dal concreto, è capace di
immaginare e ripetere ciò che gli viene suggerito. In questo modo, con la sua
capacità di immaginare e di ipotizzare delle soluzioni ai problemi che gli
vengono proposti, egli sviluppa la creatività trovando soluzioni di gioco varie
ed articolate; non essendo più vincolato a regole precostituite, è capace di
crearle e di saperle applicare al variare delle situazioni di gioco.
Nell’ottica
sportiva le trasformazioni cognitive di quest’età forniscono quindi enormi
vantaggi per quanto riguarda l’apprendimento della disciplina sportiva
praticata. Egli sarà in grado di cominciare ad apprendere alcuni elementi di
tattica di gioco, sarà più capace di valutare in anticipo gli effetti dei suoi
comportamenti motori. Il giovane infatti diviene capace di ritardare la sua
risposta motoria (es. il passaggio) dopo aver ipotizzato la soluzione ottimale.
Questo cambiamento è di fondamentale importanza perché determina la possibilità
di una scelta ragionata della soluzione tattica. Tutto questo non avveniva
nell’età precedente dove il gesto motorio era più istintivo ed immediato. Non
bisogna comunque dimenticare che l’età cronologica non deve spingere il tecnico
a pensare che tutti abbiano raggiunto certi traguardi a livello intellettivo.
Lo sviluppo affettivo - emotivo
L’individualità
dello sviluppo, la precocità o la tardività, generano situazioni di disagio che
condizionano emotivamente ogni aspetto dell’esistenza del soggetto in età
evolutiva. Il disagio e l’ansia dell’adolescente sono le conseguenze del
periodo evolutivo in corso, delle modificazioni psichiche e fisiche che
accompagnano il suo viaggio verso la maturità.
Egli
non riesce a definire, comprendere, strutturare la sua identità che spesso
risulta contraddittoria, fatta di passato (la sicurezza del vissuto infantile)
e di futuro (l’ideale di adulto) ma senza un presente autentico e rassicurante.
La
percezione di sé si dissolve e deve essere ricostruita pena un senso di
non riconoscimento di sè, quindi un vissuto di estraneità che genera in uno
stato di ansia per un’identità che stenta a definirsi. Certamente lavorare con
gli adolescenti non è un’impresa di poco conto in quanto le contraddizioni, gli
alti e bassi, gli sbalzi di umore ed i cali di motivazione sono all’ordine del
giorno.
Sul
versante affettivo il giovane tende a ricercare la sicurezza della propria
identità.
I
bisogni di autonomia lo portano ad avere un rapporto di odio e amore con
l’adulto. Egli tende ad attaccare le figure adulte ma nello stesso tempo a
copiarle ed emularle tanto da far propri i comportamenti e i pensieri di altre
persone o gruppi attraverso l’identificazione.
Lentamente
diviene capace di vivere emotivamente come sue le esperienze altrui.
La
paura di non valere, un’autostima fragile, lo spingono a vivere l’esperienza
calcistica come un modo di definire il proprio valore in assoluto.
Lo sviluppo morale - sociale
Dal
punto di vista psicosociale, i gruppi tendono ad allargarsi e ad assumere
connotazioni di tipo eterosessuale. Il ragazzo sente il bisogno di essere
apprezzato, integrato ed identificato come membro del gruppo. Questo favorisce
la motivazione in quanto il partecipare all’esperienza sportiva lo appaga anche
sul versante affettivo. Nell’esperienza calcistica i compagni di squadra, se
non esiste troppa rivalità, gli fanno nascere il desiderio della progettualità
di gruppo, dello spirito cooperativo. Ricavarsi un proprio spazio all’interno
del gruppo, essere amato e popolare tra i compagni, lo gratifica e lo fa sentire
importante.
Se
però il gruppo calcistico è troppo ricco di invidie e rivalità egli può sentire
la necessità di appartenere ad un gruppo più rassicurante, quello che viene
definito il gruppo dei pari. Il gruppo dei pari è un gruppo esterno
all’esperienza calcistica, composto da coetanei, dove si sente accettato e dove
si confronta con persone che vivono i suoi stessi problemi.
Il
tecnico deve essere capace di stabilire con il ragazzo un rapporto in cui vi
sia fermezza e autorevolezza ma non autoritarismo.
Il
tecnico capace deve soprattutto scoprire quali sono le motivazioni personali
che possono essere gratificate attraverso l’esperienza sportiva. E’ importante
il dialogo ed è indubbio che più il tecnico saprà comunicare con i suoi
ragazzi, facendoli sentire responsabili, e più l’esperienza calcistica diverrà
un’esperienza formativa di tutti gli ambiti della personalità.
Le
abilità sociali sono ormai consolidate ma è possibile che nel gruppo, tra i
ragazzi più grandi, ci sia qualche “furbetto” che cerchi di imbrogliare per
vincere. La trasgressione è un atteggiamento naturale ma, se il ragazzo ha
veramente assorbito i valori dello sport, del rispetto del proprio avversario,
se ha compreso il concetto di regola e di contesto sociale, sentirà meno il
bisogno di trasgredire e più il bisogno di assumere un comportamento leale, in
campo come nella vita; il tecnico dovrà sempre disapprovare il comportamento
antisportivo anteponendo sempre la correttezza al risultato.
Lo
sviluppo morale procede con le proprie conquiste ponendo le basi per il
passaggio, secondo il
modello
di Kholberg, dal livello convenzionale a quello post - convenzionale: il
ragazzo con il
tempo
comprenderà che le regole sono convenzioni sociali, che esistono dei principi
morali e che la
giustizia
e l’uguaglianza sono dei principi superiori.
PROFILO DELL’ISTRUTTORE NELLA SCUOLA CALCIO
Allenare ed educare i giovani al gioco del calcio non è un compito
semplice in quanto, occorre che il tecnico sia in grado di miscelare qualità
tecniche, tattiche, educative, psicologiche e comunicative tenendo sempre in
considerazione le fasce d’età a cui si rivolge.
Deve inoltre conoscere e tenere presente i vari processi che regolano la
maturazione fisica e la presenza di quelle fasi sensibili che sono alla base
dello sviluppo delle capacità coordinative, fondamentali nell’esecuzione dei
gesti tecnici ecco perché è preferibile che l’istruttore di scuola calcio sia
un laureato in scienze motorie.
Per l’allenatore dei giovani calciatori essere in possesso di queste
qualità è determinante al fine di ottenere dei risultati gratificanti, sia per
i ragazzi dal punto di vista tecnico ed educativo, sia per la società, per la
formazione di bravi calciatori. Pertanto, nonostante il ruolo di istruttore sia
una figura nata e consolidatasi all’interno del volontariato, le competenze
professionali a lui richieste sono molteplici e di alto spessore culturale.
Gli allenatori delle squadre del settore giovanile dovranno costituire
un modello invidiato dalle altre società: i giovani aspiranti calciatori
dovranno sentirsi attratti e stimolati a tesserarsi.
La pazienza deve essere una caratteristica preponderante di questa
figura, come pure la passione per questo lavoro. Tecnica, aspetti cognitivi,
coordinazione e rapporti consolidati: ad ogni età la giusta dose. Capacità di
leggere la realtà e capacità d’ascolto sono presupposti fondamentali di chi
insegna calcio. Nella continua evoluzione del calcio moderno, anche la figura
dell’allenatore si deve adeguare e innovare. L’allenatore del terzo millennio
deve continuamente rifarsi il “look”, deve cioè formarsi e aggiornarsi, per
restare al passo con i cambiamenti richiesti dal gioco e dai ragazzi. La sola
abilità nel mostrare il gesto tecnico non basta, deve soprattutto conoscere il
modo migliore per trasmettere il suo sapere e farlo acquisire in modo duraturo
alle nuove leve. Deve soprattutto saper cambiare e riadattare la propria
programmazione in base alle nuove abilità acquisite dai ragazzi.
Nella
sua formazione l’allenatore deve tener conto dei seguenti fattori:
mantenere un’alta motivazione
per ricercare un aggiornamento continuo teso ad arricchire il proprio bagaglio
metodologico e didattico;
conoscere le proprie
caratteristiche per programmare il miglioramento di quelle più limitate ed
esaltare le qualità;
mettere a punto una propria
filosofia mirata all’ottimizzazione degli approcci ed allo sviluppo delle
risorse individuali dei ragazzi;
individuare le caratteristiche del
contesto ambientale e le peculiarità dell’atleta in rapporto all’età.
Fondamentale per l’allenatore è il distaccarsi dagli schemi fissi e
degli stereotipi d’allenamento degli adulti, schemi che impediscono
originalità, creatività e il miglioramento anche delle qualità possedute.
Il ragazzo è il soggetto delle attenzioni e del lavoro dell’allenatore
L’Allenatore è il regista delle esigenze primarie del giovane calciatore
IL RUOLO DELL’ ISTRUTTORE NELLA SCUOLA CALCIO
L’allenatore
ha in ogni caso un ruolo ed una azione direttiva in quanto: valuta, sceglie e
decide. E’ comunque essenziale che la propria autorità sia basata sulla
competenza.
Con le
categorie dei più piccoli (Piccoli Amici) si cercherà di mettere i ragazzi
subito a loro agio, procurando interesse e divertimento sin dalla prima seduta.
Con i più grandi (Pulcini ed Esordienti) cercheremo di ottenere la loro piena
disponibilità, motivandoli adeguatamente su determinati obiettivi da conseguire
assieme. Una squadra unita sopperisce alle carenze tecniche con lo spirito del
collettivo e può raggiungere risultati insperati. Questa è una grande lezione
anche dal punto di vista educativo.
LE INTERAZIONI CON I GENITORI
Il rapporto con i genitori è uno dei più delicati da gestire, a causa di un
motivo molto semplice: ogni genitore è portato a sopravvalutare il figlio, a
considerarlo il migliore, e ad essere in ultima analisi il suo primo tifoso.
Per questo motivo è consigliabile organizzare una riunione all’inizio
della stagione con tutti i genitori dei ragazzi per stabilire delle norme
di comportamento, e far notare che il comportamento negativo del singolo si
riflette sul gruppo.
L’allenatore dovrà farsi accettare dai genitori come educatore del figlio,
cercando nel contempo di aumentare il loro bagaglio di cultura sportiva,
esponendo gli obiettivi del suo lavoro, sia quelli motori che quelli educativi
e morali. All’allenatore dei giovani calciatori, per impostare il rapporto sui
giusti binari, non è consigliabile avere un rapporto troppo cameratesco con i
genitori, nè tanto meno inoltrarsi con essi in discorsi calcistici.
Sarà da tenerli in attenta considerazione quando ci parlano dei problemi di
crescita del figlio, dei problemi scolastici o fisici. In questo caso dovremo
apprezzare quello che ci trasmettono come fossero un ponte tra i ragazzi ed i
risultati agonistici ed educativi prefissati.
Il giovane allenatore dovrà ricordare sempre di evitare, in presenza di qualche
genitore, di emettere giudizi positivi o negativi sugli altri componenti
della squadra.
Parlare dei singoli solo con il genitore interessato. I genitori oltre a creare
incomprensione con l’allenatore possono essere causa di ansia per il figlio,
creargli insicurezza o desiderio di strafare, caricarlo di troppe
responsabilita’
- Conoscere le
tecniche del gioco e le fasi di applicazione.
- Motivare e
sostenere gli interessi individuali e di gruppo,
creando situazioni favorevoli al raggiungimento dei traguardi previsti
controllando tempi e spazi, il tutto determinato da un contesto
ambientale.
- Favorire l’incontro
con i vari saperi motori per sviluppare forme di linguaggio che esaltano
l’espressività e la creatività.
- Valorizzare tutte
le esperienze con massima attenzione alla gratificazione individuale e di
gruppo.
- Integrare durante
il gioco i rapporti individuali considerando gli aspetti emotivi ed
affettivi anche e soprattutto nel momento in cui i singoli assumono un
ruolo nel gruppo.
- Programmare un
piano di lavoro che preveda obiettivi da raggiungere, contenuti e modalità
d’azione da selezionare, variabili da inserire, verifiche e valutazioni da
effettuare nei momenti ritenuti opportuni.
- Concordare
il programma con il responsabile tecnico e con la società
AZIONE
DIDATTICA DELL’ISTRUTTORE:
- Spiegare
- Dimostrare
- Controllare
l'esecuzione
- Correggere
VALUTAZIONE
DELL’ISTRUTTORE DA UN PUNTO DI VISTA METODOLOGICO E DIDATTICO
Questi aspetti sia negativi che positivi stanno a valutare
l’operato dell’istruttore durante una lezione;
ASPETTI POSITIVI:
Metodologia:
1. illustra, spiega e dimostra;
2. corregge in positivo;
3. osserva lo svolgimento della lezione;
4. interviene chiarendo i problemi attraverso l'autovalutazione dei
giovani calciatori;
5. incoraggia dopo un errore;
6. verifica che tutti abbiano compreso le sue spiegazioni;
7. corregge gli errori uno alla volta a partire da quelli più rilevanti;
8. dà feedback positivi in risposta ad azioni corrette;
9. loda e rinforza l’impegno degli allievi;
10. coinvolge tutti nell’attività;
11. coinvolge gli allievi nella presa di decisioni importanti per il
gruppo;
12.motiva al gruppo le proprie decisioni;
Didattica:
13. utilizza esercitazioni considerando gli
14.aspetti di polivalenza e multilateralità;
utilizza giochi di situazione;
15. utilizza giochi a tema;
16. utilizza partite didattiche finalizzate ad un coinvolgimento e alla
partecipazione attiva dell'allievo stimolandone l'iniziativa e la creatività.
ASPETTI NEGATIVI:
Metodologia:
17. si mostra poco disponibile a discutere con gli allievi circa le
proprie scelte;
18. si mostra indifferente/ignora agli errori degli allievi;
19. non gratifica le azioni positive degli allievi;
20. corregge in modo punitivo gli errori;
21. ignora i progressi individuali;
22. corregge in negativo;
Didattica:
23. utilizza attività ed esercitazioni non adatte
all'età dei giovani calciatori;
24. la seduta di allenamento mostra lunghe
pause tra un'esercitazione e l'altra;
25. nelle esercitazioni gli allievi hanno poche occasioni per cimentarsi
nelle proposte
dell’istruttore (es. ci sono lunghe file)
LE REGOLE DELL’ISTRUTTORE
L’istruttore rispettando determinate regole, è professionalmente
all’altezza del suo operato.
a seguire ecco i comportamenti che l’istruttore deve fare propri:
Arrivare al campo, se possibile, almeno trenta minuti prima
dell’inizio della seduta
d’allenamento (lo stesso per gare, incontri e manifestazioni).
Indossare per gare e manifestazioni il materiale della
Scuola Calcio
Essere sempre muniti di numeri di telefono necessari
(bambini tesserati, tecnici,
medico e altro).
Indossare immediatamente la muta da “istruttore” Scuola
calcio per
essere riconoscibili dai famigliari dei bambini e da eventuali
nuovi “arrivi”.
Preparare il materiale, assicurarsi che i palloni siano
gonfi e che l’impianto elettrico
sia funzionante.
Se possibile, preparare il campo con il materiale previsto
per la seduta
d’allenamento almeno dieci minuti prima dell’inizio della seduta.
NON parlare con i genitori di questioni tecniche.
NON permettere MAI ai genitori di entrare in campo.
Non lasciare MAI i bambini soli a “scorrazzare” con i
palloni per il campo.
Durante la seduta (60/80 minuti) non formare “capannelli”
chiacchierando con gli
altri istruttori.
Alla fine della seduta accompagnare i bambini fino agli
spogliatoi.
Se possibile, non andare TUTTI subito a fare la doccia, ma
assicurarsi che almeno
un paio di istruttori restino a disposizione di bambini e
famigliari per risolvere
eventuali problemi.
Assicurarsi che i bambini vengano “ritirati” da famigliari o
conoscenti (i genitori
devono comunicarlo prima!!!).
Prima di lasciare gli impianti assicurarsi che il materiale
sia a posto, in ordine e
pulito (palloni e delimitatori lavati); casacche sporche in un
unico contenitore.
Dare la convocazione per la gara scritta.
Non trasportare nella propria macchina i bambini (a meno che
non ci sia assoluta
necessità).
Se è previsto l’utilizzo del pulmino della società non si
può usare il mezzo proprio
per recarsi nel luogo della convocazione.
Alla fine del primo giorno d’allenamento della settimana
preoccuparsi di sapere il
programma della settimana stessa (di tutte le squadre della Scuola
Calcio )
Il risultato viene DOPO, i miglioramenti dei bambini PRIMA.
Non esprimere MAI giudizi tecnici su giocatori tesserati di
altre società.
Questi consigli falli diventare regole.
LA PROGRAMMAZIONE DELLA LEZIONE
La lezione di calcio rappresenta la singola tappa della programmazione
generale e serve per ottimizzare il lavoro da svolgere ed il tempo disponibile.
Il compito dell’istruttore sarà quello di prendere delle decisioni riguardanti
le attività scelte ed il metodo da utilizzare. È una fase necessaria per
svolgere una buona lezione:qualunque sia l’esperienza dell’istruttore, non può
fare affidamento alla capacità di improvvisare per risolvere i problemi.
La lezione dovrà essere caratterizzata da un buon impegno motorio e da
frequenti feed-back.
L’obiettivo generale di una seduta per una squadra di settore giovanile, sarà
quello di produrre apprendimento abbinato al divertimento.
Nella programmazione della seduta, oltre agli obiettivi, ai mezzi operativi ed
ai relativi metodi, si sceglieranno anche i metodi di valutazione.
Programmando la lezione si riducono i tempi morti, favorendo una continuità
utile all’apprendimento dei giovani. La lezione che scorre fluida, senza
difficoltà, consente all’allenatore di concentrarsi sui comportamenti dei
ragazzi, sulle informazioni di ritorno e da fornire al gruppo, sull’aumento
della motivazione con incoraggiamenti, lodi e correzioni. E’ più produttivo
operare in queste condizioni perché l’azione dell’istruttore nei confronti
degli allievi è molto efficace.
Fasi della programmazione:
1)
ANALISI DELLA SITUAZIONE,considerata come il momento in cui
l’istruttore prende visione delle caratteristiche del gruppo che ha a
disposizione; si deve individuare il livello socio-ambientale, il livello
tecnico-motorio di ciascun bambino e quindi del gruppo;
2)
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI da migliorare nel corso
dell’anno o all’interno delle singole unità didattiche.Possiamo definire 4 aree
nelle quali dobbiamo intervenire:
a)
Area psico-motoria;
b)
Area tecnica;
c)
Area tattica e cognitiva;
d)
Area delle capacità morali.
3)
ORGANIZZAZIONE E SCELTA DELLE ATTIVITA’ E DEI CONTENUTI
scegliendo le situazioni di lavoro, le proposte operative e i vari giochi con i
quali si tenta di raggiungere i vari obiettivi che sono stati prefissati;
4)
SCELTA E ORGANIZZAZIONE DEI METODI chiedendosi non “cosa insegno”, ma “come insegno”
.Ad oggi le due modalità metodologiche sono quelle induttive e deduttive;
5)
SCELTA E ORGANIZZAZIONE DEI MATERIALI scegliendo
attrezzature e materiali in base a quelli messi a disposizione dalla società
per la quale si lavora:
6)
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ dove contano soprattutto le
conoscenze e le capacità dell’istruttore nel trasmettere quello che deve essere
appreso.Il principio da seguire è questo: ”dal facile al difficile, dal
semplice al complesso”;
7)
VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ quando l’istruttore si assicura
di aver raggiunto gli obiettivi programmati e individua così nuovi obiettivi da
perseguire per un successivo processo di apprendimento.
GLI ELEMENTI CHE INFLUENZANO LA SEDUTA
La programmazione e la costruzione della lezione sono caratterizzati da:
- programmazione annuale e settimanale: la singola seduta si colloca in
un particolare momento della programmazione, dovrà tenere conto di quello che è
già stato fatto in precedenza e di quello che si farà nella seduta successiva;
- gli incontri precedenti: nelle categorie in questione hanno importanza
relativa ma consentono ugualmente di evidenziare gli aspetti della gara e di
far comprendere ai ragazzi come l’allenamento serve a migliorare la prestazione
successiva, correggendo gli errori;
- materiale a disposizione: conoscendo la quantità ed il materiale che
si ha a disposizione si possono variare le attività e rendere più interessanti
(paletti, cinesini, coni, casacchine, over, ostacoli, porte ridotte, dimensioni
del campo, …). I palloni sono sempre l’elemento operativo più importante.
L’istruttore sapendo di poter contare su un determinato tipo e quantitativo di
materiale, saprà rendere la programmazione più varia ed interessante;
- condizioni climatiche: allenarsi con il caldo e l’umido è diverso da
allenarsi con il terreno duro per il ghiaccio oppure fangoso per la troppa
pioggia. Per questo motivo si dovranno apportare delle variazioni che
consentiranno di utilizzare la seduta in condizioni climatiche particolari, in
rapporto alle reali possibilità dei ragazzi. Nelle categorie “PICCOLI AMICI” e
“PULCINI”, è sempre utile avere a disposizione una palestra. In caso di
maltempo o situazioni climatiche avverse (in inverno le temperature rigide e le
poche ore di luce), la lezione potrà svolgersi regolarmente al coperto. Solo
così si può fornire la continuità che permette di consolidare le abilità
apprese in precedenza;
- numero di giocatori: è una variabile che condiziona fortemente le
possibilità operative e le scelte delle forme e dei mezzi impiegati nella
seduta;
- motivazione dei giocatori (disponibilità mentale): sarebbe ottimale
avere sempre in campo dei giocatori sempre motivati. Un ragazzo che appare
svogliato, preoccupato, scontroso, … è un problema da non sottovalutare;
- disponibilità dell’istruttore/allenatore: l’istruttore dovrà cercare
di arrivare al campo sufficientemente sereno e riposato per poter essere
paziente, lucido e motivato per affrontare le attività dell’allenamento;
- personalità e competenza dell’istruttore: è la garanzia della qualità
del lavoro e dei risultati raggiungibili, per i miglioramenti individuali e
collettivi.
La disponibilità mentale dell’allievo che produce motivazione, piacere,
volontà ed applicazione, dipende da:
- rapporto con l’allenatore;
- rapporto con i compagni;
- regole di gruppo;
- qualità della seduta;
- problemi familiari;
- preoccupazioni proprie della fascia d’età di appartenenza.
STRUTTURA DELLA SEDUTA
La "seduta di allenamento" deve essere interessante; i bambini
non devono partecipare pensando che siano i soliti esercizi noiosi altrimenti
non sviluppano la voglia di imparare e, poco motivati, riducono al minimo il
loro impegno e, molto probabilmente, non torneranno agli allenamenti
successivi.
Affinchè la seduta sia EFFICACE è necessario che:
· l'ambiente
sia positivo;
· l'istruttore
sviluppi interesse e partecipazione;
· ci
sia sempre incoraggiamento e gratificazione;
· l'insegnamento
avvenga per compiti;
· l'istruttore
sia autorevole;
· il
lavoro sia svolto simultaneamente;
· si
riducano al minimo i tempi di fermo;
· variare
i compiti e le attività.
Una normale seduta di allenamento può
durare da 60 a
90 minuti così suddivisi:
·
la prima fase di 10
minuti circa deve contenere un “gioco iniziale” con lo scopo di far fare
riscaldamento ai bambini;
·
la seconda fase di 20
minuti circa deve contenere “un’esercitazione analitica” legata agli obiettivi
che si vogliono raggiungere nella seduta di allenamento;
·
la terza fase di
circa 15 minuti deve contenere una “situazione di gioco” come per esempio le
sfide 1 contro 1, 2 contro 2, 2 contro
1 ecc;
·
la quarta fase di
circa 15 minuti deve contenere il “gioco a tema”,come può essere una
partita a 3 tocchi,una partita con al
posto delle porte delle aree di meta, ecc.;
·
la quinta fase deve
durare dai 20 ai 30 minuti e deve contenere un “gioco libero” che generalmente
consiste nella classica partitella per
far divertire i bambini. Questa fase è fondamentale nell’allenamento e non deve
mai mancare.
GLI OBIETTIVI ED I MEZZI OPERATIVI
Ogni seduta deve contribuire al miglioramento del giocatore, producendo dei
progressi nei vari aspetti della prestazione, nelle capacità motorie, tecniche,
collaborative, nella capacità di analisi della situazione e nelle capacità
decisionali.
E’ noto che la maggior parte delle abilità e delle capacità da sviluppare non
si ottengono subito; è perciò importante stabilire quali sono i miglioramenti
da ricercare, perché saranno i miglioramenti gli obiettivi di ogni seduta: sarà
sui miglioramenti raggiungibili e raggiunti che si faranno le valutazioni al
termine della seduta e di un periodo particolare.
La scelta del mezzo operativo è la risposta ad un obiettivo da raggiungere, ad un
problema da risolvere.
· Che cosa si vuole ottenere?
· Dove vogliamo migliorare/fare migliorare?
Analizzando i problemi che si incontrano, il tecnico seleziona le esercitazioni
che ritiene più idonee al raggiungimento dell’obiettivo prefissato.
Non esistono mezzi operativi adatti ad una categoria piuttosto che ad un’altra,
in quanto si agisce sugli elementi che caratterizzano l’esercitazione o il
gioco proposti e questi ultimi potranno essere utilizzati in tutte le
categorie.
Sarà importante cercare di trovare la giusta combinazione ideale da utilizzare
per conseguire gli obiettivi operativi che si sono prefissati.
Le attività sono il mezzo utile per l’acquisizione di nuove condotte motorie.
Possono essere imposte, suggerite dall’istruttore o scelte dai ragazzi sotto la
proposta del tecnico.
Ogni attività è costituita da contenuti, racchiude l’informazione motoria o
comportamentale indispensabile all’acquisizione di capacità ed abilità
determinate.
Per creare interesse e curiosità si possono inserire all’interno della seduta,
nuovi giochi o esercizi, oppure un particolare che caratterizzi il mezzo
operativo: una nuova regola in un gioco noto o una diversa modalità esecutiva
in una esercitazione tecnica.
Sarà l’istruttore a scegliere se sviluppare un’attività piuttosto che un’altra,
dedicandovi maggior tempo.
Il mezzo efficace deve avere delle caratteristiche ben definite:
- essere simile alle condizioni di gioco;
- far conseguire all’allievo una buona percentuale di successo;
- procurare un buon “transfert”.
Sono da considerare efficaci le esercitazioni che hanno il miglior rapporto fra
il tempo dedicato ad un determinato obiettivo e l’effetto ottenuto.
Ogni mezzo operativo ha la possibilità di essere regolato ed adattato alle
esigenze o al livello delle capacità dei propri allievi.
Un mezzo operativo efficace è contraddistinto proprio dalla sua versatilità,
caratteristica che consente di utilizzare la stessa struttura di esercitazione
per poter conseguire un altro obiettivo. In questo modo si riducono notevolmente
anche i tempi morti della seduta, riducendo le spiegazioni ed utilizzando uno
spazio già delimitato, mirando su un’attività già nota agli allievi.
Nelle proposte operative si possono inserire delle variabili:
- esercizi con e senza opposizione;
- variazione dei numeri di giocatori;
- variazione dello spazio (forma e dimensioni);
- variazione delle zone del campo;
- variazione delle porte o delle mete dimensioni e numero;
- variazioni degli obiettivi;
- variazione delle regole;
- variazione della durata.
Minore sarà il numero di allievi, maggiore sarà l’opportunità di rapportare
l’esercitazione al singolo; minore è lo spazio, maggiori sono le difficoltà nel
controllo e nella trasmissione della palla; minore è lo spazio, più breve è il
tempo per sviluppare il gioco e maggiore sarà la velocità di esecuzione del
gesto tecnico richiesto.
L’allenatore deve essere il grado di modificare alcuni elementi delle
esercitazioni se si rende conto che la situazione proposta non risulta efficace
in modo sufficiente per conseguire lo scopo prefissato.
LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’
E LA VALAUTAZIONE
FINALE
· SAPERE QUELLO CHE SI DEVE REALIZZARE (raggiungere il fine della
programmazione).
· SAPER FAR FARE AGLI ALLIEVI QUELLO CHE SI E’ PROGRAMMATO (capacità di guidare
l’allenamento e capacità didattica).
· GLI ALLIEVI FANNO SULLA BASE DI QUELLO CHE E’ STATO PROGRAMMATO E PROGETTATO
DALL’ISTRUTTORE (capacità di attenzione e saper recepire l’esercitazione in
atto).
L’istruttore spiega al gruppo qual è il traguardo da raggiungere, facendo in
modo che anche l’esercizio semplice sia motivo di interesse per i singoli,
chiarendo quali sono i punti focali e mettendo alla prova il gruppo, per
verificare se riescono ad individuarli.
Gli obiettivi operativi devono essere raggiunti con livelli di difficoltà
crescenti: ritmo lento, ricerca della precisione, aumento della velocità,
inserimento di avversari prima passivi poi semi - attivi, poi in grado di
esprimersi liberamente.
Gli interventi di rinforzo dell’istruttore sono significanti nello sviluppo
della funzione didattica: gli interventi sono mirati a modificare in senso
positivo dei comportamenti, attraverso incoraggiamenti o apprezzamenti.
Il numero degli allievi condiziona la scelta dei mezzi operativi: l’istruttore
deve essere in grado di saper agire nel caso in cui si dovessero verificare
determinate situazioni; è un vantaggio per l’istruttore che potrà adattare
rapidamente ciò che sta proponendo, ma tenendo sempre come punto fisso gli
obiettivi prefissati.
Per stabilire l’efficacia della programmazione, l’istruttore al termine della
seduta dovrà considerare:
- il clima creato;
- il livello di concentrazione degli allievi;
- il livello di partecipazione degli allievi;
- il livello degli interventi didattici e degli adattamenti;
- le modifiche verificate, rispetto agli obiettivi prefissati.
In questa fase i nostri
giovani atleti, rispetto alla fascia d'età precedente, hanno più motivazioni
per l'apprendimento tecnico e quindi si sottoporranno più volentieri ad
esercitazioni tecniche di tipo analitico, che presuppongono alto numero di
ripetizioni. Questo anche dal momento che i fattori motivazionali, riguardanti
la prestazione, sono aumentati notevolmente rispetto alla categoria pulcini.
Naturalmente però i momenti ludici dovranno pur sempre costituire una parte
essenziale della seduta di allenamento tecnico, in quanto il gioco sarà ancora
sentito quale improrogabile esigenza vitale. Passando gradatamente dal facile
al difficile, si cercherà di far interiorizzare l'esatta esecuzione di tutti i
fondamentali tecnici al ragazzo. Questo mediante numerose ripetizioni di
movimenti, sia di tipo analitico sia di tipo globale, soprattutto se i ragazzi
non ne possiedono ancora la padronanza. Anche in questa categoria verrà dato un
rilevante spazio alle capacità coordinative.
OBBIETTIVI CAPACITA’ TECNICHE
|
Capacità tecniche
|
Dominio
|
saper controllare la palla
saper condurre la palla
|
Trasmissione
|
saper dare una palla rasoterra (interno piede,
esterno/collo, interno/ collo, tacco, punta)
saper dare una palla alta (interno/collo,
collo piede, esterno/collo)
saper dare la palla di controbalzo (collo
piede, interno piede, esterno/collo)
saper dare una palla al volo (interno piede,
collo piede, esterno/collo)
|
Tiro
|
saper calciare con palla a terra ferma
(interno piede, interno/collo, esterno/collo, collo piede, punta)
saper calciare con palla a terra in movimento
(interno piede, interno/collo, esterno/collo, collo piede, punta)
saper calciare una palla al volo (interno
piede, interno/collo, esterno/collo, collo piede, punta)
saper effettuare una rovesciata
|
Arresti
|
saper arrestare la palla in arrivo rasoterra
(interno piede, esterno/collo,pianta)
saper arrestare la palla in arrivo dall'alto
(interno piede, collo piede, coscia, interno/collo, esterno/collo, pianta,
petto, testa)
|
Colpo di testa
|
saper colpire una palla con la fronte
saper colpire una palla all'indietro
saper colpire la palla in tuffo
|
Cross
|
saper calciare facendo descrivere alla palla
una parabola
|
Dribbling
|
sviluppo delle varie finte (forbice, veronica,
ecc..)
|
Contrasto
|
saper contrastare frontalmente
saper contrastare lateralmente
saper eseguire una scivolata frontale
saper eseguire una scivolata laterale
|
CAPACITA' TATTICHE
In questa fascia di età si continuerà nello
sviluppo di obiettivi sia generali che specifici, dando però maggior peso,
rispetto alla categoria pulcini, a uno sviluppo qualitativo degli obiettivi
legati ai movimenti di squadra.
Obiettivi generali area tattica
|
Percezione e strutturazione spazio/temporale
|
Il tutto si baserà sull'occupazione funzionale
dello spazio di gioco. Bisogna educare i bambini in modo che ognuno riesca a
rappresentarsi mentalmente un proprio territorio in cui interagire, che può
essere riformulato a seconda degli spostamenti dei suoi compagni. Di primaria
importanza è l'allenamento della duttilità mentale del ragazzo, in modo da
indurre in lui la capacità di formulare soluzioni inerenti alle problematiche
di gioco. Fornendo al bambino la possibilità di sperimentare situazioni
nuove, attraverso esercitazioni a tema, contribuiremo in modo significativo
ad aumentare i suoi collegamenti sinapsici. Questi sono molto importanti per
l'organizzazione strutturale della mente del ragazzo, che funzionerà come una
banca dati a cui si potrà attingere in ogni situazione sia per problematiche
legate al gioco, sia riguardanti la quotidianità.
|
Rafforzamento delle dinamiche di gioco in
funzione del pensiero divergente e del pensiero convergente
|
Si dovranno rafforzare le principali dinamiche
di gioco:
1c1, 1c2, 2c2, 2c3, 3c3, 3c4, 4c4, 4c5, 5c5,
7c7, 9c9
|
Sviluppo principi tattici generali in fase
difensiva
|
Nella metà campo avversaria pressione sul
portatore di palla e raggruppamento compatto nella zona del campo di presenza
della palla. Nella nostra metà campo azione di temporeggiamento per favorire
il rientro dei giocatori rimasti temporaneamente tagliati fuori dall'azione
difensiva.
|
Sviluppo principi tattici generali in fase
offensiva
|
Con la squadra avversaria schierata in assetto
difensivo, imparare a gestire il possesso di palla. Con la squadra non ancora
schierata in assetto difensivo, imparare a verticalizzare il gioco
velocemente.
|
Obiettivi specifici area tattica
|
Sviluppo dello spazio proiettivo
|
Si cercherà di proiettare in campo un'organizzazione
geometrica e si lavorerà per cercare un'impostazione di gioco corale.
|
Principi difensivi specifici
|
Il lavoro si baserà sulla comprensione dei
concetti di:
azioni di temporeggiamento sul portatore di
palla
marcatura dell'attaccante avversario
marcatura aggressiva per favorire l'anticipo
|
Principi offensivi specifici
|
Il lavoro si baserà sulla comprensione dei
concetti di:
scaglionamento in fase di attacco
movimenti senza palla
ricerca dello spazio vuoto
circolazione rapida della palla
|
Sviluppo principali moduli di gioco a 7
|
(2-3-1), (3-2-1), (1-4-1).
|
Sviluppo principali moduli di gioco a 9
|
(3-3-2), (3-4-1), (4-3-1), (4-2-2), (2-4-2).
|
Sviluppo principali moduli a 11
|
(4-3-3), (4-4-2), (3-5-2), (3-4-3), (5-3-2).
|
PREPARAZIONE MOTORIA GENERALE
Obiettivi preparazione motoria generale
|
Miglioramento delle Capacità coordinative
|
Rafforzamento della capacità di combinazione
motoria
Rafforzamento delle capacità di equilibrio
Rafforzamento della capacità di ritmizzazione
Rafforzamento della capacità di
differenziazione
Rafforzamento della capacità di orientamento
spazio/temporale
Rafforzamento della capacità di reazione
Rafforzamento della capacità di adattamento e
trasformazione
|
Miglioramento della flessibilità e stretching
|
Esercizi a corpo libero o con utilizzo di
piccoli attrezzi.
|
Potenziamento della capacità motorie di base
(camminare, correre, saltare, lanciare, rotolare, arrampicarsi, strisciare)
|
Percorsi vari, salti, uso di funicelle,
andature, esercizi con movimenti su piani diversi, esercizi di
pre/acrobatica.
|
PREPARAZIONE MOTORIA SPECIFICA
Obiettivi preparazione motoria specifica
|
Miglioramento della capacità aerobica
|
Giochi ed attività varie, con palla, protratte
nel tempo intervallati da fasi di recupero.
|
Miglioramento della reattività neuromuscolare
e rapidità di movimento
|
Giochi ed esercitazioni per migliorare la
velocità di esecuzione di un gesto tecnico e per aumentare la velocità di
risposta agli stimoli esterni.
|
Miglioramento della forza veloce
|
Giochi ed esercitazioni che permettano di
poter aumentare la capacità di reclutamento delle fibre muscolari del
soggetto nel minoro tempo possibile.
|
Miglioramento della forza
esplosiva/elastico/reattiva
|
Giochi ed esercitazioni che permettano di
poter aumentare la capacità di risposta ad uno stimolo esterno.
Esercitazioni, possibilmente in forma ludica, che contengano balzi,
multibalzi esplosivi, ostacoli bassi e corsa balzata. Tutto sempre a carico
naturale. Il numero di toccate sarà basso e ogni esercitazione supportata da
un recupero adeguato.
|
SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE CAPACITA' COORDINATIVE E LORO APPLICAZIONE NEL
CALCIO
CAPACITA’ COORDINATIVE
|
APPLICAZIONE
|
Capacità di adattamento e
trasformazione: la capacità che ha
l’individuo, in base alle variazioni percepite o dedotte dalla situazione,
di portare delle modificazioni all’azione programmata in precedenza e di eseguirla
in modo, del tutto o in parte, diverso.
|
· 1 contro 1
· Rimbalzi o deviazioni anomali del pallone
· Variazioni del programma motorio in relazione alle iniziative
dei compagni o degli avversari
|
Capacità di equilibrio: la capacità di mantenere tutto il corpo in condizioni di stabilità, sia
in fase statica sia dinamica sia in volo, o di ripristinare questa
condizione dopo aver eseguito dei movimenti.
|
· Cambi di direzione e dribbling
· Contrasti
· Colpo di testa
· Gioco in acrobazia
· Tuffo del portiere
|
Capacità di reazione: la capacità di iniziare ed eseguire rapidamente un movimento in
rapporto ad una qualsiasi sollecitazione e di eseguirlo alla velocità
adeguata rispetto al compito motorio da svolgere.
|
· Tempi di attivazione della risposta
motoria in rapporto alla situazione creatasi
· Reazione alle finte
· Ripartenze
|
Capacità di differenziazione:
la capacità di selezionare il giusto grado di
tensione muscolare secondo l’esigenza motoria.
|
· Il dosaggio della forza nei
passaggi e nei controlli
· Finte
· Il ritmo di corsa
|
Capacità di ritmizzazione: la capacità di eseguire la sequenza cronologica specifica di un
determinato movimento.
|
· Variazione del ritmo dei movimenti
secondo le situazioni
· Adattamento ai tempi e ritmi di gioco
|
Capacità di orientamento: la capacità di definire e variare la posizione ed i movimenti del corpo
nello spazio e nel tempo, in riferimento ad un campo di azione definito.
|
· Posizione in campo
· Valutazione della traiettoria e velocità della
palla
· Valutazione della velocità di spostamento dei
giocatori (compagni ed avversari)
|
Capacità di combinazione: la capacità di collegare tra loro – in relazione al movimento globale
del corpo diretto ad un certo scopo – movimenti di segmenti del corpo,
movimenti isolati o singole fasi di movimenti.
|
· Conduzione della palla e
passaggio
· Guida e tiro
· Saltare e colpire di testa
· Arresto della palla, passaggio o tiro
|
Capacità di anticipazione: la capacità che consente al soggetto di prevedere l’andamento, la
successione, gli esiti di un’azione e di programmare conseguentemente i
propri compiti motori.
|
· Lettura del gioco di compagni ed
avversari
· Lettura della situazione
· Visione di gioco
|
Fantasia motoria: la capacità che consente di risolvere in forma originale e creativa un
problema motorio, quindi di variare, ristrutturare nuove forme di
apprendimento
|
· Dribbling
· Finte
· Ricerca di soluzioni nuove
|
PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE CAPACITA'
COORDINATIVE NELLA CATEGORIA ESORDIENTI
Mese
|
Settimana
|
Capacità
|
Obiettivo
|
- OTTOBRE
|
1a
|
ADATTAMENTO E TRASFORMAZIONE
|
Adattamento a variabili di tipo temporale
|
2a
|
EQUILIBRIO
|
Equilibrio statico
|
3a
|
REAZIONE
|
Reazione stimolo semplice (uno stimolo
visivo o uno stimolo acustico)
|
4a
|
DIFFERENZIAZIONE
|
Esercitazioni per lo sviluppo della capacità
in relazione ad un punto fisso
|
- NOVEMBRE
|
1a
|
RITMIZZAZIONE
|
Fase ciclica
|
2a
|
ORIENTAMENTO
|
Palla capitano – Palla capitano in campo
|
3a
|
COMBINAZIONE
|
Combinazioni semplici
|
4a
|
ANTICIPAZIONE E FANTASIA MOTORIA
|
2:1 con obiettivo singolo
|
- DICEMBRE
|
1a
|
ADATTAMENTO E TRASFORMAZIONE
|
Adattamento a variabili di tipo spaziale e
temporale
|
2a
|
EQUILIBRIO
|
Equilibrio dinamico
|
3a
|
Test
|
|
4a
|
|
|
- GENNAIO
|
1a
|
|
|
2a
|
REAZIONE
|
Reazione stimolo complessi
|
3a
|
DIFFERENZIAZIONE
|
Esercitazioni per lo sviluppo della capacità
in relazione ad elementi mobili
|
4a
|
RITMIZZAZIONE
|
Fase alternata
|
- FEBBRAIO
|
1a
|
ORIENTAMENTO
|
Palla capitano in meta – Cambia posto
|
2a
|
COMBINAZIONE
|
Combinazioni complesse
|
3a
|
ANTICIPAZIONE E FANTASIA MOTORIA
|
3:2 con obiettivo multiplo
|
4a
|
Eventuale recupero per lezioni non svolte
|
|
- MARZO
|
1a
|
ADATTAMENTO E TRASFORMAZIONE
|
Adattamento e trasformazione della
situazione
|
2a
|
EQUILIBRIO
|
Equilibrio in volo
|
3a
|
REAZIONE
|
Reazione complessa in situazioni di gioco
|
4a
|
DIFFERENZIAZIONE
|
Esercitazioni per lo sviluppo della capacità
in situazioni di gioco
|
- APRILE
|
1a
|
RITMIZZAZIONE
|
Fase variata
|
2a
|
ORIENTAMENTO
|
La prigione
– 4 porte con prigioniero
|
3a
|
COMBINAZIONE
|
Combinazioni specifiche
|
4a
|
ANTICIPAZIONE E FANTASIA MOTORIA
|
5:5 con obiettivi di gioco variabili
|
- MAGGIO
GIUGNO
|
1a- 4a
|
Test - Rinforzo per le capacità carenti
|
|
|
|
|
|
PROGRAMMAZIONE ANNUALE TECNICO TATTICA
MESE
|
Cap.
Tecniche
|
Cap.
Tattiche
|
SETTEMBRE
|
Effettuazione
test
Conduzione.
Passaggio – Ricezione.
Modi di calciare.
|
Difesa
porta in sup. numerica.
Gioco senza palla.
Sistema di gioco
7>7 – 11>11.
|
|
|
|
OTTOBRE
|
Passaggio
– Ricezione.
Modi di calciare.
Colpo di testa.
Copertura della palla.
|
Difesa
della porta in inf./sup.
Temporeggiamento.
Creazione spazio.
Passaggio – Tiro.
Gioco con/senza palla
7>7 – 11>11
|
NOVEMBRE
|
Passaggio
– Ricezione.
Modi di calciare.
Colpo di testa.
Copertura della palla.
Movimento d’inganno.
|
Creazione
spazio.
Marcamento.
Gioco con/senza palla.
Passaggio – Tiro.
7>7 – 11>11
|
DICEMBRE
|
Passaggio
– Ricezione.
Modi di calciare.
Colpo di testa.
Movimento d’inganno.
Dribbling.
|
Marcamento.
Temporeggiamento.
Difesa della porta e presa di posizione in superiorità ed inf.
|
GENNAIO
|
Verifica
Lavoro
(test di verifica)
|
Verifica
Lavoro
(test di verifica)
|
FEBBRAIO
|
Passaggio
– Ricezione.
Modi di calciare.
Movimento d’inganno.
Dribbling.
|
Difesa
della porta e presa di posizione i sup./inf. 11>11.
|
MARZO
|
Passaggio
– Ricezione.
Modi di calciare.
Movimento d’inganno.
Dribbling.
|
Smarcamento.
Creazione di spazio.
Dai e Vai.
11>11
|
APRILE
|
Passaggio
– Ricezione.
Modi di calciare.
Movimento d’inganno.
|
Attacco
contro difesa con conclusione finale.
|
MAGGIO
|
Lezioni
incentrate al riepilogo generale
Fondamentali
del calcio.
|
Lezioni
incentrate al riepilogo generale
Attacco
contro difesa con conclusione finale.
|
GIUGNO
|
Verifica
Lavoro
(test di verifica)
|
Verifica
Lavoro
(test di verifica)
|